
Cosa significa correre la prima maratona? E se questa prima maratona è proprio lei, quella di New York?
Quando ero piccola ricordo che mio padre sognava di correre la Regina delle Maratone, ricordo che si era documentato e informato per poter partecipare, aveva fatto già cambiare le lire in dollari (e su questi dollari ci torno tra un po’), poi non so per quale motivo, questo sogno non si è mai avverato.
Era il 2019 e avevo iniziato da poco a correre seriamente, quando, per una serie di coincidenze, mi si è presentata l’occasione di poter correre la maratona di New York. Al momento dell’iscrizione, ad aprile, le mie gambe vantavano una distanza corsa di ben 10 km e il mio corpo non era sicuramente preparato per reggere uno sforzo tale.
Tutto mi diceva che non sarei stata pronta per affrontare quella prestazione, che non era il caso di iniziare proprio con Quella maratona. Poi, come accade spesso nella mia testa, mi sono detta “ci devi provare!, non ascoltare gli altri che dicono che non ce la farai, lo puoi fare, coi tuoi tempi, ma lo puoi fare”. L’ho presa con uno spirito leggero, ho pensato che se non ci avessi provato me ne sarei pentita per il resto dei miei giorni e che il mio sogno sarebbe rimasto nel cassetto come i dollari di mio padre. Ho scelto bene, inutile dirlo, mi sono iscritta.
Ad aprile non ci pensavo, non pensavo a cosa avrebbe comportato il preparare una maratona dall’altra parte del mondo, ma forse, col senno di poi, posso dire che è stato meglio partire con un po’ di sana ingenuità. Da aprile a novembre la mia vita e i miei pensieri sono stati galvanizzati da quell’evento, dall’attesa, dalla preparazione. Da aprile a novembre ho pensato almeno 100 volte di aver fatto una scelta avventata, soprattutto confrontandomi con altre persone sicuramente più preparate di me.
Quell’anno lo ricordo come fosse ieri, non l’ho mai scritto nero su bianco, ma l’emozione che mi pervade in questo momento mi riporta a galla esattamente quelle sensazioni, di euforia e terrore allo stesso tempo. Ho deciso di raccontare la mia esperienza perché ne parlo sempre come una delle cose più emozionanti della mia vita, il mio racconto felice, la mia rivincita. Ho deciso di raccontarlo anche perché, quest’anno, esattamente come 5 anni fa, la maratona di New York sarà il 3 novembre.

La preparazione mi ha subito fatto capire che con una maratona non si scherza. Il sacrificio è elevato, le tabelle sono rigide e a volte la voglia proprio manca. La voglia di uscire a correre con la pioggia e magari dover affrontare 32 e più km da sola, sola con i miei gel e i miei pensieri a farmi compagnia, sola con i dolori che a un certo punto arrivano a bussare in ogni parte del corpo, anche quelle che apparentemente non stai utilizzando.
La preparazione è stata formativa, anche e soprattutto a livello mentale. Non avevo bisogno di rigore, dal momento che la mia mente è già abbastanza rigida nei suoi schemi, ma ho imparato la dedizione e il sacrificio, quelle che servono per portare avanti i propri obiettivi in modo serio e appassionato.

Sono arrivata a New York con una gamba infortunata, impaurita, stanca, emozionata e nella valigia i vestiti di mio padre da indossare sopra la divisa e da lasciare prima della partenza negli appositi bidoni per lo smistamento di quei capi ai senzatetto. Vestiti accuratamente scelti, la felpa e i pantaloni della divisa del suo gruppo sportivo. Nel portafoglio Il Dollaro portafortuna, proprio uno di quei dollari stagionati che da tempo facevano compagnia al suo cassetto. Insomma un carico emotivo forte, tanto tanto forte.
I giorni prima della maratona ho visitato New York, una città che mi è sembrata fuori di testa, così come quello che mi stavo apprestando a fare per i miei standard. Ricordo che le sere prima facevo sempre un piantino, mi sembrava tutto così grande, tutto così solenne e io piccola piccola e sicuramente non nelle condizioni fisiche migliori.
Potrebbe sembrare, detta così, che io l’abbia vissuta male, ma in realtà si vive di emozioni forti, tristi, felici, l’importante è che ci siano, ci tengono vivi, danno un senso alle nostre vite.
La sera prima della gara i pensieri corrono veloci, la pasta in compagnia sicuramente non sarà mai nelle quantità e con i condimenti giusti di quella provata a casa, e il cambio dell’ora proprio quella notte sicuramente non tranquillizza.
La sveglia suona alle 4:00, ora locale. La colazione in hotel passa in silenzio, un po’ per l’orario, un po’ per l’ansia che solo chi è li può capire. Tutto pronto nella borsa apposita che verrà caricata sul furgoncino diretto a Central Park, tappa bagno, lavata di denti e si parte con il pullman che ci scaricherà come un trasporto bestiame nel village a Staten Island.

Una volta qui i miei occhi non riescono a contenere l’immensità. Un campo enorme con 52000 mila persone, cecchini sui ponti, elicotteri che volano sopra le nostre teste, distese di bagni chimici come latrine, gente di tutti i tipi avvolta nei loro capi destinati a una nuova vita. Qui ci trascorreremo tante ore, tantissime, prima di partire. Il mio pensiero in quel momento va a casa, penso che, guardando l’evento in TV, si staranno chiedendo dove sono in mezzo a tutta quella gente.

Poi arriva il momento, ci si incammina verso la griglia, siamo migliaia. Inizio ad abbandonare pezzi di abbigliamento sulla via che mi porterà alla partenza, ripongo Il Dollaro nel mio manicotto con i colori della bandiera italiana (un po’ di sano patriottismo non guasta mai), penso alla mia gamba dolorante e mi chiedo come farò a convincerla a correre per 42 km e 195 metri, ma poi mi dico che ormai sono lì e non posso più tornare indietro. Lo sparo (!), eccolo, ma io partirò 11 minuti dopo, tempo di smaltire migliaia di persone.
Sono stata sciocca a non scrivere subito le mie sensazioni, ora è passato molto tempo, ma ci sono dei momenti e dei passaggi che ricordo come fosse ieri.
Ricordo che al decimo chilometro avevo già fame, del resto, ero sveglia da praticamente 8 ore, e ricordo di aver pensato ai vari errori commessi nella mia alimentazione; l’inesperienza, ahimè, la si paga sempre a caro prezzo. Ricordo infatti di aver preso volentieri i grissini offerti da dei bambini a lato strada, lo so, non si fa, ma dovevo pur mangiare qualcosa di solido.
Ricordo le urla di incoraggiamento delle persone che mi incitavano come fossi parte della loro famiglia, ricordo una città enorme in festa, piena di colori, in perfetta antitesi con il silenzio tombale del quartiere ebraico attraversando Brooklyn, e poi, i poliziotti che ballavano, i rapper da film con catenozze d’oro al collo e casse portatili nel Bronx, i cartelli motivazionali, tra cui uno in particolare al 33esimo chilometro con una semplice domanda: “WHY?”. Al 33esimo chilometro il perché te lo chiedi eccome, e la risposta a quella domanda nasce dentro di te, tra i dolori a ogni muscolo e articolazione, davanti a quel muro che, sì, esiste.
Ricordo che proprio entrando a Manhattan, ormai in piena crisi, mi si è parato davanti un signore che correva indossando una canottiera con la scritta “GO, DONATO, GO” e mi è scappato un sorriso per quanto la vita sia pazzesca. Mio padre si chiama Donato.

Da quel momento ricordo che la mia testa ha fatto uno sforzo mai provato fino a lì. Ha scavato in tutta la sua memoria, ha scavato in tutti i suoi ricordi, in tutti i suoi punti deboli, in tutte le sfumature del mio essere, ha messo tutto insieme per trovare le parole giuste per convincere il mio corpo ad andare avanti. Lo sapevo che non sarei stata pronta fisicamente, ma alla faccia di chi diceva che non ce l’avrei mai fatta, dovevo andare avanti.
Il Dollaro dal 37esimo chilometro è sempre stato nelle mie mani, l’ho stretto forte, ho pensato che in quel momento stavo vivendo ciò che mio padre non aveva vissuto, mi sono sentita fortunata, forse ho sorriso e sono andata avanti.
All’ingresso a Central Park mancano ancora 4 chilometri all’arrivo, non è finita. Ricordo perfettamente il dolore dei crampi che hanno preso il sopravvento e mi hanno costretta a fermarmi alla tenda del soccorso dove una simpatica donnona di colore ha iniziato a tirarmi pugni col ghiaccio nel quadricipite; benissimo ho pensato, che momento esilarante.

Gli ultimi 4 chilometri li ho fatti con le lacrime pronte ad uscire, ricordo che la gente urlante addosso a quel punto mi infastidiva, ma al tempo stesso mi dava la carica per compiere quell’ultima fatica. E poi, eccolo, l’arrivo che vedevo in televisione la domenica da piccola quando si passava la mattina sintonizzati per vedere il trionfo dei primi.

Ecco, il mio non è stato così trionfale, e di tutto questo viaggio è stato il momento che, paradossalmente, ho amato meno. Al mio arrivo non c’era nessuno ad aspettarmi, ero in mezzo a migliaia di persone, ma nessuno era lì per me.
Questa esperienza mi ha insegnato anche questo, che ci sono viaggi che avvengono solo dentro di noi, che ci cambiano, ci fanno crescere, ci insegnano nuove cose sul nostro conto, cose che nessuno, se non noi, potrà mai capire fino in fondo. La condivisione è però qualcosa di magico, un abbraccio con chi ci è più caro rende quel momento ancora più sacro. La mia maratona di New York è il mio racconto felice, ma, mi toccherà rifarla per avere un traguardo degno di un’esperienza così unica.

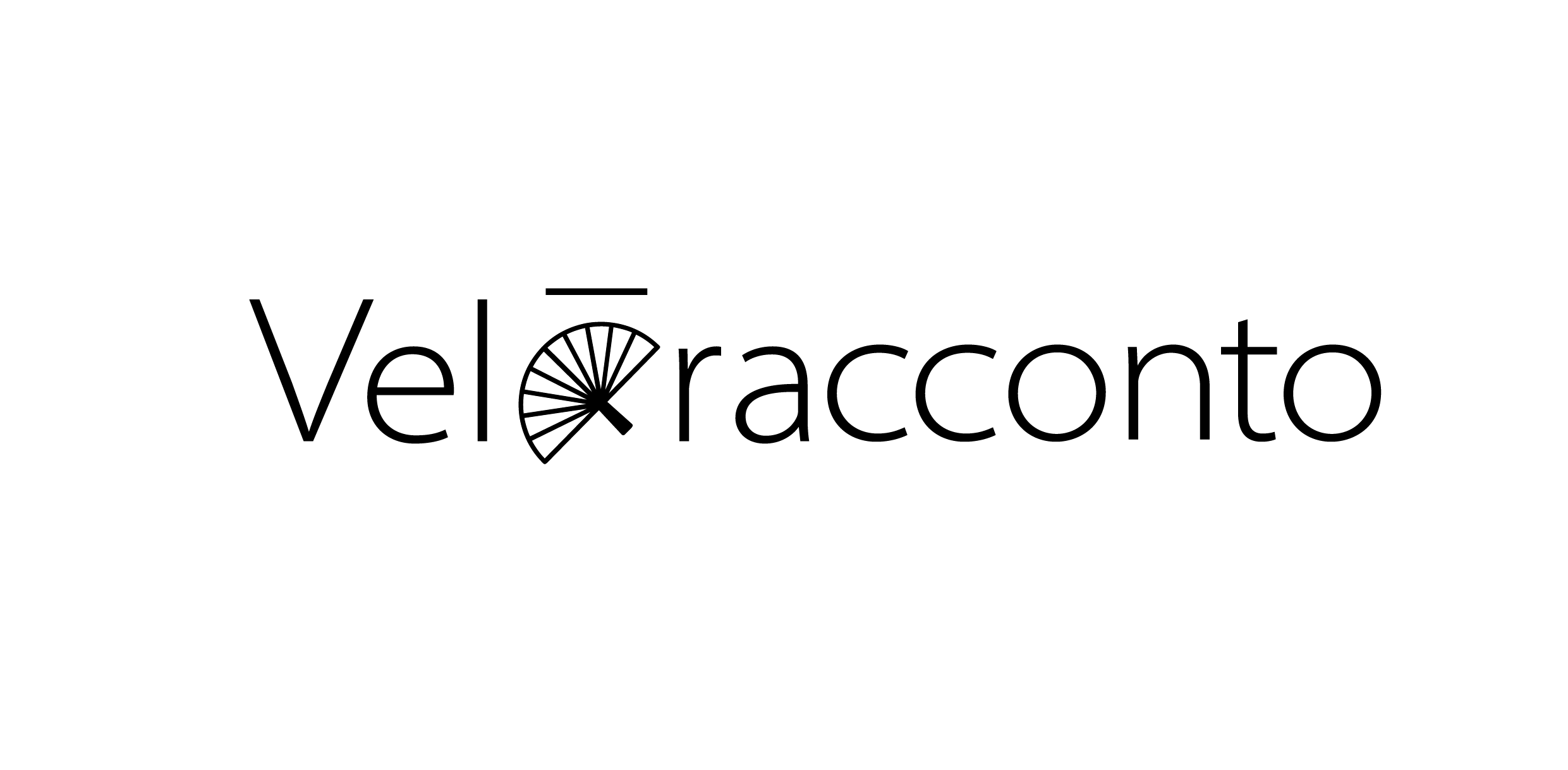
Lascia un commento